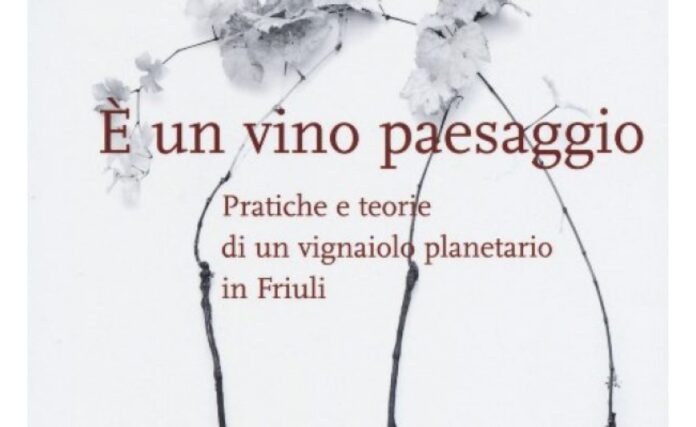Non è un articolo dedicato a un’azienda, ma a un libro e ai suoi protagonisti. In verità non è nemmeno un articolo, ma un messaggio che nasce in Friuli e interessa il mondo. Quantomeno il nostro, di mondo.
Un libro, dunque. Letto e riletto più di una volta. L’ultima, in occasione di una mia lezione sul bianco friulano al PerBacco di Mondolfo, un posto che tra parentesi vi consiglio.
Il titolo, È un vino paesaggio, promette una visione d’insieme che la lettura mantiene e rilancia fino all’ultima pagina, regalandomi ore liete.
La bellezza sconfinata dell’opera di Simonetta Lorigliola, scrittrice triestina in evidente stato di grazia, merita un’ampia diffusione. È questa la ragione per cui ho chiesto spazio a Daniele Biguzzi, che ringrazio infinitamente.
È un vino paesaggio lo farei leggere nelle scuole. E lo regalerei ai ragazzi – e forse anche ai meno giovani – che non sanno distinguere una pianta di kiwi da una di vite. Lo regalerei a chiunque di noi per riempire le numerose voragini di indifferenza su cui ogni giorno camminiamo. Lo regalerei perché porta in superficie l’intelligenza, la creatività, il sogno e l’ambizione di due esseri umani speciali: Lorenzo Mocchiutti e Federica Magrini. Il loro esempio merita di essere conosciuto.
Vignaioli umani e indipendenti. Umani perché detestano gli schemi robotici, le ripetizioni non filtrate, le paranoie ideologiche. Indipendenti perché revocano in forse luoghi comuni e petizioni di principio, facendo come pare a loro, nel bene e nel male. Il loro esempio è in quelle parole scritte da Simonetta; è nella loro vita, nel loro lavoro, nei loro vini. Leggete il libro e bevete le loro bottiglie, tutto vi sembrerà chiaro e coerente.

È un vino paesaggio è un contenitore di idee con una visione culturale, sociale, etica, economica e dunque politica della vita. E ci dice che la sensibilità, l’osservazione, la dedizione, non si acquistano al negozio di enologia di turno come sacchi di bentonite, non te li regala il consulente onnisciente e onnipresente. Sono qualità che si acquisiscono solo attraverso due sentimenti formidabili, che cambiano l’esistenza di ciascuno di noi: l’amore e la passione. Lorenzo e Federica sono innamorati l’uno dell’altra, e poi del loro mestiere. E parteggiano con passione per la loro terra, per le loro vigne, per la loro comunità.
Questi due cuori che palpitano e queste due teste che pensano si percepiscono con clamorosa trasparenza nei vini che Lorenzo e Federica producono. Bianchi e rossi fatti non per sfidare il mondo, non per vincere concorsi di bellezza, ma per raccontare una visione di Friuli che è tanto personale quanto credibile.
Attenzione: l’atteggiamento dei vini di Vignai da Duline, senza le amplificazioni della tecnologia, è su due piedi remissivo. In questi liquidi tace il varietale più garrulo a favore di un’intonazione più intima della terra e dell’aria.
Che poi l’aria friulana è nordica, porta nuvole, porta pioggia, porta instabilità. Il Friuli è questo: sole a intermittenza, temporali frequenti, precipitazioni sopra la media. Tribolazioni che nei vini si sentono e si devono sentire: non possono somigliarsi i vini della provincia di Trapani e i vini della provincia di Udine, per dire. Da Trapani voglio il caldo salmastro, da Udine un tepore salino. La differenza non è affatto sottile.
Invece quante volte ci capita di non saper distinguere vini tra loro lontanissimi? Tante, troppe.
Troppe volte non sappiamo dare un nome proprio ad alcun vino, perché tutto ci pare comune, tutto ci pare figlio di un cliché, incapace di dichiararsi fino in fondo, come incapsulato in una protesi di gomma.
Lorenzo e Federica senza mai perdere di vista il rispetto per il consumatore, che ha il diritto di bere un vino pulito e sano, hanno preso la strada dell’umanesimo enologico, rendendo umano il loro mestiere di artigiani, dando voce e anima ai loro vini. Come burattinai innamorati dei loro personaggi. Ci provano e ci riescono.
È chiaro che vini originati e concepiti senza escamotage, in una terra come il Friuli, non possono essere vini esplosivi, è più probabile il contrario; non saranno mai prepotenti, ma timidi; non saranno mai larghi e densi, semmai cesellati, graduali, raffinati.
La scuola friulana ha seguito nei bianchi un percorso a singhiozzo, che dai vini esili e smagriti di quarant’anni fa è approdato alle lunghe macerazioni dello scorso decennio, passando attraverso le cremosità boisé degli anni Novanta. Lorenzo e Federica non seguono in tal senso alcuno schema, provano a comprendere le esigenze dei singoli vitigni e delle singole vigne, usano il legno solo per far evolvere i vini in una dimensione più naturale e minerale, senza conciarli di aromi; svolgono fermentazioni spontanee e scelgono un percorso che è in sintonia con le loro scelte agronomiche.
Non intendo dire che i loro vini sono migliori degli altri, intendo dire che i loro vini sono il frutto di un percorso personale, individuale, peculiare. È questa la strada che va consigliata ai vignaioli artigiani.
Lorenzo e Federica in campagna fanno molta attenzione all’uva, al benessere delle vigne e alla biodiversità dell’ambiente in cui le viti vivono, si nutrono, riposano, vegetano, fruttificano e lignificano. Le piante hanno un ruolo nevralgico nell’attività dei Vignai da Duline.

Vogliono conservare i loro ceppi a lungo e al meglio, e per custodirli occorre trattarli con rispetto, trovando un equilibrio congeniale alla loro esistenza e alla loro resistenza.
La fisiologia della pianta funziona in modo anarchico, proprio come il cervello umano. Un buon vignaiolo come un buon educatore, deve limitarsi ad aprire il varco per la libera e autoregolata espressività.
Studiare e rispettare la fisiologia della vite non è una deriva bucolica, né un percorso a ritroso e antimoderno. Il vigneto non deve essere progettato a partire dalla tecnologia, semmai è vero il contrario. Al centro stanno la vite, l’ambiente, il contesto agricolo e il paesaggio. Il resto, solo se occorre e di conseguenza.
La collezione di vecchie vigne di Lorenzo e Federica non ha eguali in Friuli, solo Mario Zanusso (I Clivi) può contare su vigne altrettanto mature. Salvaguardare vigne che hanno radici profonde e un ancestrale adattamento al luogo in cui sono piantate significa affrontare le stagioni (sempre più bizzarre e imprevedibili) con una maggiore stabilità. Una pianta matura sopporta meglio gli estremi termici, gestisce meglio i periodi di siccità, trova un equilibrio maggiore durante le precipitazioni estreme, anche in virtù di un carico produttivo di norma più ridotto e di grappoli più spargoli. Una pianta matura non necessita di tagli vigorosi, di potature drastiche in estate e di una gestione robotica della chioma, perché il suo vigore è per natura più moderato, il suo comportamento meno altalenante.
Invece in tante zone del mondo conta ormai più la finanza del tempo che farà domani: e così un vigneto, oltretutto sempre più fragile ed esposto alle malattie, viene rimpiazzato dopo venticinque anni, forse meno. È il mercato, bellezza.
Mercato che non conosco e di cui non mi occupo, ma sono certo che la piccola fetta di vino di qualità del mondo, deve andare in una direzione molto più umana.
Non mi riferisco al vino industriale, di massa: quello è pacifico che sia prodotto con altri criteri e consumato senza alcun atteggiamento critico.
Ma il vino di qualità, il vino d’autore, il vino di terroir, il vino artigiano, il vino culturale, il vino per il quale noi ci muoviamo, per il quale visitiamo cantine e banchi d’assaggio, quello deve rispondere a delle logiche più umane e deve posizionarsi nei pressi del cuore.
Il vino, il nostro vino, deve saper dialogare con la sua terra, deve avere in sé il trasporto emotivo di chi lo ha fatto. E la terra deve funzionare bene per alimentare al meglio una pianta, non deve essere intossicata da concimi chimici, compattata fino all’asfissia, desertificata da diserbi cruenti.
La strategia agronomica di un vino umano deve rispettare il più possibile il meccanismo delicato – e ormai da tempo fragilissimo – messo a punto da madre natura nel corso dei millenni.
Lorenzo e Federica si accollano il rischio di non fare vini perfetti per una certa idea di mercato, e non puntano a costruire il super vino che piace tanto a quel super giornalista, ma accettano di fare vini che sono quello che sono. Sia inteso: che siano quello che sono, ma al meglio possibile, perché qui non si fanno elogi alla sciatteria, tutt’altro.
Penso al tormentone di Luca Carboni: non voglio fare l’amore, voglio un miracolo. Parafrasandolo, io non voglio bere un grande vino, voglio un calice che mi racconti chi è.
Se non è un miracolo, poco ci manca.
* Francesco Falcone è nato il sei maggio del settantasei a Gioia del Colle. È un degustatore indipendente, divulgatore e scrittore.